Chip, reshoring, cultura della sicurezza: la sfida per il dominio nel XXI secolo secondo Aresu
La corsa per il dominio nella produzione strategica dei chip, la partita globale del reshoring industriale, la sfida Usa-Cina, il ruolo di Taiwan: il nuovo saggio di Alessandro Aresu, Il dominio del XXI secolo, in uscita il 31 ottobre per Feltrinelli, racconta le dinamiche più complesse e strategiche della corsa tecnologica e geopolitica tra le grandi potenze globali, Usa e Cina in testa, e le ricadute mondiali di una partita a tutto campo.
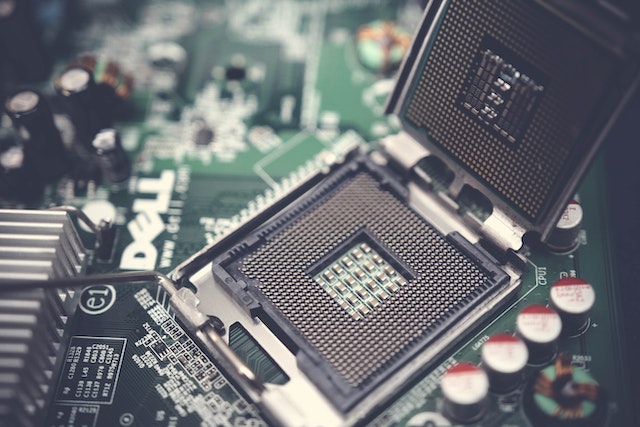
E proprio dei temi contenuti nel suo saggio l’analista geopolitico e consigliere di Palazzo Chigi nel governo Draghi parla oggi in un’intervista a tutto campo con l’Osservatorio, di cui è sempre graditissimo ospite.
Dal capitalismo politico alla corsa per il dominio. Usa e Cina, due “imperi allo specchio”. Come si muovono i trend della competizione a due anni dal cambio della guardia alla Casa Bianca?
Nel mio libro “Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia” (Feltrinelli) cerco di guardare il conflitto tra Stati Uniti e Cina a partire dalla storia e dai cambiamenti che riguardano alcune supply chain globali, in particolare i semiconduttori e le batterie, più che da una semplice analisi dell’attualità. La guerra è visibile nella retorica delle potenze e nei loro gesti, ma è invisibile nel senso che si applica a oggetti minuscoli o a componenti di cui raramente consideriamo l’importanza.
Questo percorso ci consente di vedere una prospettiva apparentemente “vincente” della Cina, quella sulle batterie, e una prospettiva “perdente”, quella dei semiconduttori. Penso che sia una chiave di lettura utile per leggere le tendenze della competizione e ricordarci quanto, nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, si debba considerare il ruolo di altri Paesi, come i produttori e i gestori di materie prime critiche, e come le potenze manifatturiere dell’Asia Orientale.
Il tema del “ritorno” della sicurezza nazionale come perno dominante della politica è ormai di pubblico dominio. Quali settori sono più investiti, a quasi tre anni dallo scoppio della pandemia?
Come sai, mi occupo da circa dieci anni di questioni come il ritorno della sicurezza nazionale, l’interesse nazionale, il ruolo dello Stato nelle politiche industriali e tecnologiche, i settori strategici, e abbiamo spesso discusso insieme dei miei saggi e dei miei libri su questi temi. Ovviamente mi compiaccio della diffusione di questi temi nel dibattito pubblico, perché sono importanti.
Allo stesso tempo, proprio quando i propri punti di vista diventano più diffusi, bisogna considerarli con uno sguardo critico e autocritico maggiore. Per fare qualche esempio, non è vero che il successo di ASML, la grande azienda dei Paesi Bassi dei macchinari per i chip, sia dovuto al ruolo dello Stato. In quel caso, i fondi del governo olandese o della Commissione Europea hanno avuto un ruolo estremamente ridotto nella sua storia rispetto ad altri elementi decisivi (la mentalità imprenditoriale degli ingegneri che l’hanno composta; il rapporto con fornitori e clienti; la decisione della quotazione in borsa negli anni ’90; le autorizzazioni alle acquisizioni fornite dagli Stati Uniti). Non è neanche vero che il capitalismo di Stato cinese abbia costituito in solitudine il dominio della filiera delle batterie: Robin Zeng di CATL non era certo favorito rispetto ad altre aziende che avevano legami più chiari col Partito; quindi, il suo successo è dovuto anche ad altri fattori. E così via.
Inoltre, ora che siamo immersi in una corsa alla sicurezza nazionale, è sbagliato ritenere che ogni settore possa diventare strategico. Cosa succede, se tutto è sicurezza nazionale? Come è possibile gestire l’onnipresenza di ciò che è strategico? Semplicemente, non è possibile e non si può fare. Un mondo di sfere di sicurezza nazionale totalizzanti è destinato a bloccarsi. Allora, bisogna avere qualche linea di demarcazione, per non morire di incertezza. La cosa importante è trovare un equilibrio, perché i paesi che funzionano sanno liberare e sfruttare gli investimenti privati. Se invece per varie ragioni (incertezza nel breve-medio periodo, vincoli eccessivi, autorizzazioni infinite) tali investimenti sono imprigionati, allora non combiniamo niente. La capacità di attrarre e liberare investimenti deve trovare un difficile equilibrio per convivere con strumenti di economia di guerra che, oramai, dovrebbero comunque far parte del nostro orizzonte di pensiero, come fanno parte di quello degli Stati Uniti, come cerco di dimostrare attraverso il racconto dello sviluppo delle sanzioni e dei controlli alle esportazioni.
Reshoring e friend-shoring sono diventati termini sempre più noti ultimamente. Appare sempre più difficile, però, portare all’indietro le lancette della storia per le potenze occidentali. La strategia di ritorno delle industrie a casa avrà successo?
Di reshoring e di ritorno manifatturiero gli Stati Uniti parlano in modo sostenuto da almeno dieci anni. Ma il dibattito originariamente risale agli anni ’80 e all’ascesa giapponese, come del resto tanti temi che ritornano nel nostro presente.
Nell’amministrazione Obama, c’erano diverse iniziative sul reshoring e il ritorno manifatturiero, e si era diffusa la volontà di “riprendere” il modello tedesco nei suoi punti forti sulla formazione tecnica. I piani di reindustrializzazione degli Stati Uniti, in quel caso, non hanno funzionato. Alcune cerimonie roboanti di Trump, come la fabbrica in Wisconsin di Foxconn che ricordo nel libro, si sono risolte nel nulla. E il sistema tecnico tedesco rimane molto meglio di quello degli Stati Uniti.
In sostanza, cosa sta succedendo adesso? Si ripete quella strada, ma ciò avviene con un consenso politico più ampio negli Stati Uniti, dovuto a una maggiore consapevolezza della competizione con la Cina, del fatto che la competizione con la Cina si giochi anche sulla manifattura avanzata. Incide di più la sicurezza nazionale e quindi un commercio che ragiona sulla logica dell’amicizia, che presuppone anche l’inimicizia. Quindi servono “amici” perché l’interdipendenza coi “nemici” può rendere vulnerabili.
La cosa veramente nuova, a mio avviso, è lo studio delle supply chain strategiche (semiconduttori, batterie, materie prime critiche, farmaceutica), effettuato dall’amministrazione Biden: il documento della Casa Bianca “Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth”, di giugno 2021. Mi spiace per l’uso del termine “resilienza”, di cui mi piacerebbe vedere l’abolizione, ma si tratta comunque di un documento di grande importanza. Questa consapevolezza delle supply chain strategiche mancava sicuramente, nell’epoca dell’amministrazione Obama, e ha portato un patrimonio conoscitivo per le decisioni che ha fatto salire la qualità degli interventi offensivi degli Stati Uniti.
In tal senso, che ruolo può avere la fuga delle imprese dalla Cina a contesti come il Vietnam?
Gli Stati Uniti non hanno caratteristiche, in termini di costo del lavoro ma soprattutto di organizzazione di manodopera diffusa e gestione dei processi formativi e industriali, paragonabili ai paesi dell’Asia orientale. La forza dell’Asia orientale, in termini di aggregazione regionale, non può essere eguagliata, e peraltro Shannon O’Neil ha mostrato che la capacità di integrazione regionale degli Stati Uniti è stata molto inferiore a quella dei grandi hub asiatici. Ma questo agli Stati Uniti non importa, perché c’è consenso politico e sociale sul ritorno in patria (non in Canada o in Messico, eh) della grande organizzazione manifatturiera, della manifattura ad alta tecnologia.
Quindi gli Stati Uniti dicono: da un lato, sovvenzioniamo le aziende perché ciò avvenga (alcune aziende, sicuramente nei semiconduttori e nelle batterie), dall’altro lato erigiamo barriere verso la Cina, limitandola con controlli alle esportazioni sempre più occhiuti e con la condizionalità delle politiche industriali che includono le aziende sulla base della loro azione per limitare la presenza cinese nella supply chain. Si tratta di un programma mastodontico e molto interessante, ma non è detto che abbia successo, perché bisogna considerare fattori culturali, fattori umani, e si dovrà a un certo punto affrontare il fatto che il circolo dell’istruzione tecnica, della formazione e dell’organizzazione della manifattura avanzata statunitense sia molto indietro rispetto alle capacità asiatiche e di alcuni europei, nonché i cambiamenti delle condizioni politiche.
Alla luce di tutto ciò, l’obiettivo di limitazione della Cina può essere comunque conseguito attraverso le altre potenze manifatturiere dell’Asia orientale, quindi con le Apple di turno che puntano più sul Vietnam che sul “ritorno a casa”. Quindi con una regionalizzazione anti-cinese che coinvolga in modo forte alcune economie dell’Asia orientale, che presentano vantaggi organizzativi, gestionali e dei talenti rispetto agli Stati Uniti.
Nei tuoi studi ti concentri molto sul ruolo strategico dei chip. Che ruolo può avere in tal senso Taiwan come perno della competizione Usa-Cina?
Sui chip, in premessa: penso che presto ci dimenticheremo del ruolo strategico di quest’industria, perché sta arrivando un ciclo di ribasso, per molti versi è già in corso. L’industria funziona attraverso cicli e passeremo dall’estremo in cui tutti parlavano di “chip shortage” all’estremo in cui si sottovaluterà l’industria perché molte aziende taglieranno gli investimenti in conto capitale. Ma l’importanza dei semiconduttori non sta in termini primari nel fatto che dobbiamo proteggerci da dinamiche e oscillazioni che continueranno a far parte del mercato, sta nel ruolo di alcune aziende fondamentali e in alcuni prodotti. Solo per fare un esempio, ricordo quello che dice il rapporto dell’amministrazione Biden sulle supply chains del 2021, a pagina 56: il supercomputer Aurora del Dipartimento dell’Energia dell’Argonne National Laboratory è passato da Intel a Tsmc come fornitore per i ritardi dell’azienda statunitense sui processi tecnologici più avanzati.
Quanto a Taiwan, subisce il suo stesso successo. Nel primo capitolo del mio libro, parlo del secolo di Morris Chang. Che vuol dire? Morris Chang è nato nel 1931. Il suo secolo potrebbe finire attorno al 2031, per esempio, con un’invasione cinese di Taiwan. Oppure, Morris Chang ha lasciato la nascente Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Il suo secolo potrebbe finire nel 2049, con la Repubblica Popolare che non ha ripreso Taiwan nel centenario, o che ormai nel tentativo si è fatta troppo male, e ormai deve combattere profondi problemi demografici.
Ma al di là delle suggestioni sulle date, il secolo di Morris Chang è il segno della sua grande capacità industriale e manageriale. Il veterano dell’industria dei semiconduttori è andato a Taiwan – sempre nei “decisivi” anni ’80 – e con la sua azienda, Tsmc, ha impresso un cambiamento molto significativo (sulla base degli studi di geniali ricercatori come Lynn Conway e Carver Mead): la separazione di una funzione produttiva su vasta scala (le grandi fabbriche, cosiddette fab) dalle capacità pure di design, con la nascita corrispondente di straordinarie aziende dedicate alla progettazione (e quindi senza fab, cosiddette fabless), tra cui le Qualcomm, Nvidia, Amd dei nostri tempi. Questa rivoluzione e soprattutto il modo con cui è stata eseguita (tecniche organizzative, garanzie di protezione di proprietà intellettuale, varie forme di “design rules”, direbbe Carliss Baldwin, fino all’ottimizzazione attraverso l’intelligenza artificiale, poi estrema fiducia nel rapporto con clienti e fornitori, produzione e gestione costante di talenti, investimento costante in ricerca e sviluppo), tutto ciò ha portato a una posizione di grande preminenza di Tsmc nella capacità computazionale avanzata. Anche se in questo settore tutti dipendono da tutti, chi più chi meno. Tsmc non è certo autosufficiente. Però è determinante e fa il suo mestiere, su vari temi, meglio degli altri.
Questo capolavoro è il cosiddetto “scudo di silicio” di Taiwan, che funziona così: siccome Tsmc e il suo ecosistema sono così importanti per il mondo, siccome tutti dipendono da Tsmc, allora un’azione violenta su Taiwan non ha senso. Tsmc funziona come deterrenza. Ora, come ammette lo stesso Morris Chang in discorsi recenti, questo tiene solo se ragioniamo solo secondo criteri economici e non secondo criteri politici, che ovviamente rientrano nell’equazione, visto che parliamo di Taiwan, e ora ci rientrano maggiormente. La fine del secolo di Morris Chang è un mondo che, anche in superficie e non solo in senso profondo, a volte ragiona senza considerare i criteri economici, e di questo le stesse aziende devono per forza tenere conto.
E l’Europa? Nei mesi scorsi abbiamo visto come la guerra in Ucraina abbia marginalizzato ulteriormente il Vecchio Continente come attore geopolitico. Che ruolo può avere nella competizione globale?
Per quanto riguarda la competizione tecnologica, l’Europa ha sicuramente capacità importanti. Nel libro ricordo la storia di aziende incredibili come ASML, Zeiss e Trumpf. Dobbiamo ricordare poi che i giganti dei gas industriali sono francesi e tedeschi, e che nel nostro continente esistono aziende eccellenti in alcune nicchie della supply chain dei semiconduttori, come la nostra Technoprobe.
Allo stesso tempo, io uso la storia di Selçuk Bayraktar, forse la più inquietante che racconto nel testo, per lanciare un allarme: attenzione, c’è un paese molto importante, la Turchia, dove a un certo punto un ingegnere che studiava al MIT ha detto letteralmente che non voleva essere leader solo nel kebab ma pure nei droni, e ha realizzato quello che diceva, contrariamente a pronostici “razionali”. E facendolo ha mobilitato migliaia di persone, migliaia di giovani per l’obiettivo di una leadership dell’alta tecnologia, e in questo momento continua a farlo, questa enorme mobilitazione è in corso. Con una gigantesca fame di sviluppo tecnologico che si concretizza anche in armi letali.
Secondo me invece noi non viviamo così: non viviamo con l’orgoglio di ASML, Trumpf, Technoprobe o le altre aziende. Nessuno o quasi sa cosa siano. Sono letteralmente invisibili. La quotazione di De Nora, il destino di Comau: ce ne importa davvero qualcosa, in termini popolari, oppure preferiamo interessarci a vicende meno importanti? Nessuno, o quasi, si appassiona per le capacità chimiche europee e il loro futuro. Non ci mobilitiamo. Ce ne importa davvero poco, in termini collettivi, pochissimo. E poi non abbiamo capito – come opinioni pubbliche e come classi dirigenti economiche – che le tecnologie sono duali e quindi bisogna abbandonare le velleità dei nostri veicoli di investimento di non incidere nell’ambito militare: è insensato e stupido.
Quali sono, a tuo avviso, i campi tecnologici di frontiera su cui si giocherà il dominio del XXI secolo?
I campi sono noti, le liste e i rapporti dei vari governi ne sono pieni. Quindi il punto non è solo dire: semiconduttori, aerospazio, cybersicurezza, batterie, intelligenza artificiale, alcuni procedimenti chimici che riguardano molti altri settori in modo trasversale, eccetera.
Non è quello il problema, altrimenti saremmo tutti allo stesso livello. Non basta la tecnologia di frontiera, in alcuni ambiti serve l’industrializzazione di vasta scala, attraverso prodotti migliori di quelli altrui.
E poi, servono le persone. I campi tecnologici non vivono in un mondo astratto, senza le competenze delle varie nazioni, ma vi sono strettamente legate. Una volta il direttore del GCHQ rivendicava con orgoglio di essere il maggiore datore di lavoro di linguisti nel Regno Unito e uno dei maggiori datori di lavoro dei matematici.
Per conservare e aumentare le proprie capacità nazionali, bisogna sempre avere in mente il tema delle competenze, soprattutto con un’intensità crescente, con una competizione crescente. Come dice il mio amico Enrico Sangiorgi, dati alla mano, gli ingegneri elettronici che formiamo non sono abbastanza: quindi abbiamo un problema che bisogna affrontare, anche sul piano culturale, come per molte altre competenze tecniche e scientifiche con cui dobbiamo acquisire molta più familiarità.
Quale futuro per l’Italia in quest’ottica? Come possiamo giocare al meglio le nostre carte?
L’Italia a mio avviso deve applicare alle sue realtà industriali il lavoro che Paolo Cerruti chiama “deep supply chain”, e che cito nel libro.
Nella nostra epoca l’intervento dello Stato si amplia. Su questo non c’è dubbio. Ma l’intervento dello Stato ha senso reale solo se abbiamo una comprensione profonda delle supply chain che ci coinvolgono, se su questo si sviluppano competenze nelle imprese e nei nostri apparati: per esempio, in che modo imprese chimiche, meccaniche, della robotica o del packaging possono trovare nuove prospettive in supply chain che si stanno sviluppando o su cui vogliamo investire per ragioni di sicurezza? Sono questioni fondamentali per salire di livello nella competizione tecnologica e sicuramente nel mondo qualcuno ci sta pensando; se ci pensa anche l’Italia, può avere un ruolo. Se l’Italia non ci pensa, avrà un ruolo minore. A ciò bisogna aggiungere – dal lato delle imprese – la precondizione di conoscere a fondo e con molta attenzione le sanzioni, i controlli sulle esportazioni e i loro effetti, cosa su cui insisto da qualche anno nei miei libri e nei miei saggi.
Quindi penso che gli Stati debbano sviluppare capacità di studio su questi temi e l’Italia deve farlo al meglio: è importante conoscere, qualche volta per deliberare e qualche altra volta invece per “liberare” meglio energie che invece non devono essere certo dirette dallo Stato. E secondo me questo lavoro sulla profondità delle supply chain, come tanti altri, idealmente non andrebbe mai delegato a società di consulenza. Bisogna invece sviluppare competenze interne, dello Stato e dei suoi apparati, delle imprese a livello interno, e scommettere in esse. Bisogna conoscere meglio le imprese e le loro esigenze, studiare l’evoluzione delle supply chain in modo profondo, per comprendere meglio i nostri punti di forza e di debolezza, ed essere meno sorpresi da un futuro che comunque saprà scombinare le carte.
L'articolo Chip, reshoring, cultura della sicurezza: la sfida per il dominio nel XXI secolo secondo Aresu proviene da Osservatorio Globalizzazione.
